Tempo di Quaresima A – 2. Domenica
Il tema delle letture di questa domenica è quello dell’incontro con Dio. Nella prima lettura si racconta che Abramo lo ha incontrato nell’atto stesso di ricevere una chiamata, quella di lasciare patria, clan e famiglia e di avviarsi verso una terra sconosciuta. Una decisione molto avventata e rischiosa in un contesto sociale come quello in cui viveva il patriarca. Come contropartita riceve tre promesse: egli riceverà una benedizione da trasmettere a tutti, diventerà progenitore di un grande popolo, otterrà in dono una terra nella quale questo popolo potrà soggiornare. Belle speranze! Ma intanto Abramo è a capo di un piccolo gruppo di migranti, ha una moglie sterile e, quando arriverà alla terra promessa, si accorgerà che essa è già abitata da altri. C’è di che scoraggiarsi. Come ha potuto Abramo credere in questa promessa? È Dio quello che ha incontrato o è il prodotto di una mente malata?
Il racconto riportato dal vangelo ci riporta alle stesse drammatiche domande. Gesù ha appena preannunziato per la prima volta la sua morte e risurrezione, smentendo le attese trionfalistiche dei suoi discepoli. Ora si sta recando a Gerusalemme, dove le sue predizioni si realizzeranno. In questo contesto l’evangelista riporta lo strano episodio della trasfigurazione nel quale Gesù appare contornato da una luce divina. Mosè ed Elia, che appaiono accanto a lui, rappresentano rispettivamente la legge e i profeti. Sono loro che hanno tenute vive lungo i secoli le promesse fatte ad Abramo in mezzo a parziali realizzazioni e grandi disastri. Ora in Gesù si manifesta pienamente il piano di Dio che sta per realizzarsi. Ma non nei termini che Pietro aveva immaginato quando lo aveva indicato come il Messia. Come per Abramo quello che si profila è un fallimento! E la voce dal Cielo dice ai discepoli: «Ascoltatelo!». È duro seguire uno che sta per essere condannato a morte credendo che sia lui a salvare il mondo.
Nella seconda lettura viene ripreso un tema caro a Paolo: la salvezza è un dono gratuito di Dio, che non si ottiene mediante le opere buone, ma mediante la fede. Ma per ottenerlo bisogna saper ascoltare, come la voce dal cielo ha suggerito ai discepoli. Ciò significa non cessare mai di credere e di sperare. E soprattutto bisogna essere disposti a pagare di persona.
L’incontro con Dio ha luogo quando si crede che il mondo migliore annunziato da Gesù sia possibile. Perché solo da questa fede nasce quel rapporto con Dio che sta all’origine di tanti altri rapporti nei quali si rende già presente nell’oggi quel mondo nuovo che si spera. Perché il mondo nuovo non si realizza con grandi imprese ma attraverso rapporti che trasformano le persone.

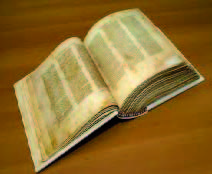

Commenti recenti