Tempo Ordinario A – 29. Domenica
La liturgia di questa domenica propone un tema molto attuale, quello cioè del rapporto tra fede e politica. Nella prima lettura si parla di Ciro, un re persiano che ha abbattuto il potente impero babilonese e si è impadronito dei territori che gli appartenevano. Per i giudei esuli in Babilonia è stato il segnale della riscossa, in quanto Ciro ha emanato un editto con il quale permetteva a loro, come a tutti i popoli che erano stati deportati dai babilonesi, di ritornare nella propria terra. Il profeta che ha scritto questo testo vede in Ciro addirittura l’«eletto» (Messia) «l’uomo della provvidenza» e gli annunzia una particolare predilezione da parte di YHWH, il Dio dei giudei. Anche se lui non lo conosce, Dio lo ha scelto come strumento per realizzare il suo progetto di salvezza. Il potere politico è dunque legittimo ma solo nella misura in cui promuove il bene comune.
Nel vangelo viene riportata subito all’inizio una frase di appezzamento nei confronti di Gesù, tanto più valida in quanto pronunziata dai suoi avversari: Gesù annunzia con franchezza la via di Dio e non guarda in faccia a nessuno. Dopo questa introduzione, i suoi interlocutori gli chiedono se sia lecito pagare il tributo a Cesare: essi sanno che rifiutandolo aderiva ai movimenti di ribellione contro i romani mentre approvandolo andava contro gli umori di tanti suoi connazionali. Gesù risponde con la frase famosa e spesso ripetuta: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Si tratta di un testo che lungo i secoli è stato interpretato nei modi più svariati e applicato alle situazioni più diverse. Con questa frase, presa nel suo contesto originario, Gesù non vuole dire che il potere romano è legittimo, ma rifiuta di aderire a un’opposizione al regime che faceva ricorso a metodi violenti. Al tempo stesso però, in sintonia con tutto l’insegnamento biblico, sottolinea come l’unica cosa importante, a cui non si può e non si deve mai derogare, sia l’impegno di «dare a Dio ciò che è di Dio», cioè di sottomettersi a lui, nella ricerca del suo regno e della sua giustizia.
Nella seconda lettura Paolo elogia i destinatari del suo scritto per la loro fede operosa, il loro amore e la loro speranza. Per lui è importante che le opere del credente siano ispirate dall’amore che ha la sua fonte nella fede e va di pari passo con la speranza in un mondo migliore.
Gesù dunque chiede al credente di intervenire nel campo politico, non con lo scopo di ottenere privilegi o di imporre schemi precostituiti, ma in funzione di una società più giusta e solidale. È chiaro che ciò può creare dei conflitti, specialmente quando una nazione è governata da un regime dispotico. In questo caso Gesù non esclude forme di ribellione o di disobbedienza civile. Quello che rifiuta è la violenza in tutti i suoi aspetti. Egli stesso ha dato l’esempio, pagando di persona per le sue scelte.

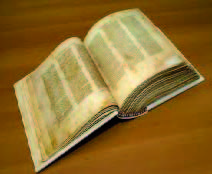

Una missione di servizio
Certo gli ascoltatori di Gesù avranno capito che cosa voleva dire con la frase: «Restituite a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Lo stesso non si può dire dei successivi lettori del vangelo, se stiamo alle innumerevoli interpretazioni che ne hanno dato. Oggi non c’è più Cesare e al suo posto è subentrato, almeno per noi, un sistema democratico, in cui il governo è votato dai cittadini. Restituire a Cesare quello che è di Cesare significa dunque stare al gioco democratico: andare a votare, osservare le leggi anche quando vanno contro il proprio interesse, sostenere i partiti che promuovono la giustizia sociale e via dicendo. Tra parentesi, per il credente tutto ciò che spetta a Cesare è dovuto anche a Dio.
C’è però un di più che Cesare non può esigere e che il credente deve restituire a Dio. Si tratta, in una parola, di quel sentimento che viene dal sentirsi tutti figli di uno stesso Padre e quindi fratelli e sorelle. È questo il nucleo centrale del messaggio di Gesù. In pratica ciò significa impegnarsi in una ricerca interiore che ha come oggetto quel Mistero indescrivibile che è l’Amore, al quale noi diamo il nome di Dio: Dio è amore e l’amore è Dio. Una ricerca guidata dal vangelo, che sfocia in un rapporto comunitario vissuto e partecipato. L’amore nasce e si sviluppa a partire dal prossimo, con cui si fa la prima esperienza della fraternità.
La comunità però non è una formazione politica, incaricata di esercitare una pressione sulle strutture della società civile. Non tocca a una comunità cristiana, e neppure alla chiesa in quanto istituzione, indicare la soluzione degli innumerevoli problemi che affliggono la società. La sua missione è eminentemente formativa, analoga a quella di una palestra nella quale gli atleti si allenano per poter poi competere nello stadio. E l’allenamento consiste essenzialmente nell’imparare a mettere in primo piano i valori della solidarietà, della giustizia e del rispetto dei diritti degli altri, a cominciare dagli ultimi. Oggi soprattutto la missione di una comunità cristiana è quella di infondere nei suoi membri e nella società la speranza in un mondo migliore, per la cui realizzazione ciascuno può dare un contributo insostituibile.
Videoconferenze: sintesi
I giudei al tempo di Gesù erano sotto il giogo romano, godevano di una limitata autonomia amministrativa, e sognavano la venuta del regno di Dio, un regno di pace e di giustizia. In gran parte accettavano la situazione ritenendo che ogni potere viene da Dio e pagavano, anche se malvolentieri, il tributo all’imperatore. Ma alcuni, chiamati briganti, pensavano di anticipare gli eventi futuri con azioni, a volte violente, contro i romani. Consentendo di pagare il tributo, Gesù rifiuta non solo qualsiasi tipo di ribellione ma anche qualsiasi rapporto con le autorità. Cesare per lui non conta. Per lui l’importante è dare a Dio quello che è di Dio, cioè praticare quei valori di giustizia e di fraternità che Dio stesso un giorno avrebbe attuato instaurando il suo regno. Nonostante la sua scelta non violenta, la sua predicazione è stata vista dai romani come una minaccia al loro potere e perciò l’hanno condannato a morte come un ribelle. Per Gesù la venuta del regno di Dio era imminente: egli non pensava certo a una chiesa che sarebbe durata 2000 anni durante i quali, a partire da Costantino, avrebbe acquisito un grande potere politico ed economico in stretto connubio con l’impero. Con l’avvento degli stati moderni si è quindi posto il problema del rapporto tra chiesa e stato secondo l’assioma: «Libera chiesa in libero stato». Ma Gesù non pensava a un potere religioso alternativo a quello dello stato. In questa nuova situazione le parole di Gesù assumono un nuovo significato: esse non propongono una divisione di poteri ma la formazione di piccole comunità, prive di ogni potere, che vivono i valori evangelici e operano nella società in favore della giustizia e della solidarietà, in collaborazione con tutti gli uomini e le donne di buona volontà.
Fede e politica. Fede è tutt’uno con la mia persona, con il rapporto che io ho con la trascendenza e che determina tutto il mio modo di essere. Non riesco a declinarla in vari settori del mio impegno come fosse frazionabile. Dalla mia fede deriva, o è aiutata, una mia etica, questa sì, interviene e determina i miei comportamenti e quindi anche il modo di intendere l’impegno politico.
Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio non necessariamente è un invito a tener separati i due piani: quello che è di Dio è come una nuvola che avvolge tutto, l’esperienza religiosa e quella laica.
Di Cesare è il nostro impegno quotidiano nella cura della nostra comunità, impegno appunto “politico” che entra nel territorio, nei rapporti tra le persone, nelle istituzioni (vedi esempio del terzo settore) per portare giustizia, solidarietà, libertà.
“Lotta come amore” si intitola il giornalino tutt’ora in vita online, fondato da don Sirio Politi uno dei primi preti operai, morto ormai da alcuni anni.
Lotta come amore: in quel “lotta” e in quel “come” è racchiuso l’atteggiamento etico che ci deve guidare … ci sono fatti che possiamo governare, altri che possiamo solo combattere con le idee nelle varie modalità possibili …
Se vogliamo che la nostra azione politica produca cambiamento dobbiamo comunque sempre lottare … si tratta di farlo con amore.
Rifiutare sempre e comunque la violenza: è un’aspirazione, una meta alla quale tendere sapendo di non poterla mai raggiungere o un impegno concreto da assolvere anche nella realtà storica, in cui spesso dittature e stermini non possono essere fermati in altro modo? Sono confusa su questo argomento, soprattutto quando da un livello individuale ci spostiamo verso una dimensione più storica e sociale.