Santissima Trinità B
Il tema delle letture di questa festa non è, come ci si potrebbe aspettare, il dogma della Trinità ma quello della manifestazione dell’unico Dio nella persona umana di Gesù. Nella prima lettura è riportato un brano del Deuteronomio che può essere considerato come la proclamazione dell’unicità di Dio. Non si tratta però di una concezione filosofica, astratta, ma dell’esperienza di Dio che gli israeliti, guidati dai profeti, hanno fatto a partire non solo dalla bellezza e dall’armonia del creato, ma anche e soprattutto dalla loro storia tribolata. La fede nell’unico Dio si è così tradotto nel progetto di costruire una vita sociale basata sulla giustizia e sulla solidarietà.
Nella lettura del vangelo Matteo racconta che Gesù, dopo la risurrezione, è apparso ai suoi discepoli su un alto monte e li ha inviati in tutto il mondo a insegnare e a fare nuovi discepoli. Il compito di guida alla scoperta di Dio, un tempo affidato ai profeti, era stato svolto in modo speciale dal loro Maestro, il cui insegnamento aveva trovato il suo pieno significato nella sua morte e risurrezione. Ora essi ricevono il compito di annunziare a tutto il mondo l’esperienza che avevano fatto a contatto con lui, perché a tutti fosse reso possibile l’incontro con Dio di cui egli era stato l’annunciatore. A Gesù viene attribuito anche l’ordine di conferire a coloro che avrebbero creduto in lui il battesimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Questo rito significa che a quanti aderiscono a Gesù è aperta la strada all’incontro con Dio. Il riferimento allo Spirito santo significa che questo incontro non è superficiale ma implica una profonda trasformazione interiore.
L’azione dello Spirito è illustrata nella seconda lettura. Essa consiste in una diversa percezione di Dio, visto non più come l’onnipotente a cui stare sottomessi ma come un Padre che ama i suoi figli. È mediante lo Spirito che il credente diventa partecipe del rapporto filiale che Gesù ha con Dio.
Fin dall’infanzia noi siamo stati abituati a considerare la Ss. Trinità come il culmine della nostra fede senza chiederci che cosa significhi per noi: era convinzione comune che si trattasse di un mistero che, come tale, non si può spiegare. Ma bisogna ricordare che la Trinità è pur sempre un’immagine con la quale uomini di tanto tempo fa hanno cercato di descrivere con categorie umane l’azione indescrivibile di Dio nel mondo. In realtà la Trinità significa che nell’esperienza umana di Gesù si è manifestato il Dio invisibile che si rapporta a noi come un Padre, cioè, fuori metafora, come colui che rappresenta i valori fondamentali nei quali troviamo il senso della nostra vita: e da questo rapporto sgorga in noi quella forza interiore che chiamiamo, sempre con una metafora, lo Spirito santo. Se uno fa questa esperienza sarà portato a condividerla con chiunque, senza pretese o pregiudizi.

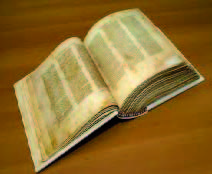

Commenti recenti