Cristo Re B
Le letture di questa domenica hanno come tema la ricerca della verità, come espressione della regalità di Gesù e della sua comunità. Nella prima lettura, la figura di uno «simile a un figlio d’uomo» è introdotta in contrasto con quattro mostri marini che rappresentano gli imperi dell’antichità. L’espressione «figlio d’uomo» non indica altro che un individuo appartenente alla razza umana. Egli è l’uomo mediante il quale Dio sconfigge le potenze del male. Al termine della visione però il figlio d’uomo viene identificato con l’Israele degli ultimi tempi, che riceverà un giorno il potere di cui si erano impossessati i grandi imperi. Il figlio d’uomo è dunque un individuo che rappresenta una comunità a cui viene conferito il regno di Dio.
Nel brano del vangelo come titolare di questo regno viene indicato un individuo, Gesù, il quale, in quanto Messia, riveste la dignità regale. Secondo il quarto vangelo Gesù, di fronte a Ponzio Pilato, lo ha dichiarato in modo esplicito, ma ha precisato che il suo regno non è di questo mondo. Ciò non significa che la sua regalità si attua in un mondo diverso dal nostro ma piuttosto che essa è diversa da quella che si attua in questo mondo. Infatti i regni di questo mondo si qualificano per la violenza con cui impongono l’ordine sociale, il più delle volte in favore di una ristretta minoranza di privilegiati. Per evitare ogni rischio di malinteso, Gesù nel vangelo afferma che il suo regno consiste nel rendere testimonianza alla verità: questa nel linguaggio biblico è l’equivalente della fedeltà con cui Dio si rapporta a questo mondo e a tutta l’umanità. Testimoniare la verità significa dunque manifestare al mondo la fedeltà di Dio. Gesù lo ha fatto non solo a parole, ma praticando lui stesso, fino alla morte, la fedeltà verso Dio e i fratelli.
Nella seconda lettura si parla invece di una regalità conferita a tutta una comunità, quella dei discepoli di Gesù. Essi devono esercitarla, come ha fatto Gesù, non mediante i mezzi del potere (utilizzati spesso anche nelle moderne democrazie), ma mediante la testimonianza della vita. Questa si identifica con il sacerdozio che compete a tutti i fedeli come comunità che dà gloria a Dio non mediante riti o cerimonie religiose, ma praticando la giustizia fra gli uomini.
La regalità di Gesù e dei suoi discepoli è dunque un antico simbolo che indica non un potere ma un servizio che i credenti svolgono in funzione del bene comune. Esso consiste nel dare testimonianza alla verità: è questo lo scopo per cui esiste la comunità dei discepoli di Gesù, i quali, come lui e insieme a lui, accolgono la fedeltà di Dio e la manifestano nel rapporto che instaurano tra di loro al servizio di tutta la società.

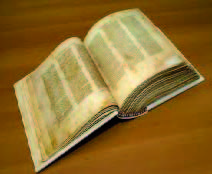

Commenti recenti