Domenica delle Palme – C
La misericordia di Dio nella passione del Figlio
Nella domenica delle Palme la liturgia ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme (vedi le letture proposte per la processione) e al tempo stesso propone una riflessione sulla passione di Gesù. Come sfondo biblico viene riportato nella prima lettura il terzo carme del Servo del Signore. In esso si sottolinea il coraggio e la determinazione con cui questo personaggio affronta le sofferenze a cui va incontro per attuare il progetto di rinascita del popolo di Israele al termine dell’esilio. Egli si sente chiamato da Dio per questa missione e intende portarla a termine unicamente con un metodo non violento.
Nel racconto degli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, Luca cerca di dare una risposta allo scandalo della morte violenta del Messia. Egli lo fa in modo narrativo, mostrando che essa è stata provocata dall’intervento di forze diaboliche che si sono scatenate contro di lui. All’origine di tutto c’è Satana che ha portato a termine la sua tentazione prendendo possesso di Giuda e tentando Simone e gli altri discepoli. Vi sono poi i membri del sinedrio, che vogliono a tutti i costi la sua morte e lo deridono quando si trova sulla croce, Ponzio Pilato che vorrebbe liberarlo ma poi cede alla pressione dei membri del sinedrio, Erode che si prende gioco di lui, i soldati che lo deridono e lo crocifiggono, uno dei due malfattori crocifissi accanto a lui che lo insulta. Sembra che tutte le forze del male, sia politiche che religiose, si siano coalizzate contro di lui per eliminare lo scomodo profeta che aveva rivelato l’infinita misericordia di Dio per tutta l’umanità.
Ma proprio il momento della sua apparente sconfitta segna l’inizio di un perdono che riguarda in primo luogo proprio coloro che si muovono intorno a lui: coloro che l’hanno crocifisso, uno dei malfattori crocifissi accanto a lui, le donne che si battono il petto e tutto il popolo giudaico che assiste alla sua morte senza far propri gli insulti rivolti a lui dai loro capi. Tutti questi dettagli mettono in risalto come il popolo giudaico non ha abbandonato Gesù, ma gli è stato vicino dissociandosi così dai suoi capi. Pur non escludendo la colpa dei giudei, Luca fa dunque un’importante distinzione, che mette in luce il suo sentimento di apertura e di comprensione verso il popolo giudaico, che si è trovato coinvolto suo malgrado in una tragedia la cui portata effettiva gli sfuggiva. Anche Pilato, pur avendo condannato Gesù, non era ostile a lui e ha riconosciuto la sua innocenza, come d’altronde ha fatto il centurione al momento della sua morte.
Sullo sfondo di questa profonda interpretazione della morte di Gesù emerge molto vivido, come nel contesto dei tre grandi annunzi della passione fatti da Gesù durante la sua vita terrena, il tema della sequela. Luca non ricorda l’abbandono dei discepoli, anche se nelle ammonizioni rivolte loro da Gesù al termine della cena è prevista la loro defezione a cui fa seguito la conversione. È lo sguardo di Gesù che provoca il pianto di Pietro, il quale potrà così confermare i suoi fratelli. Luca inoltre presenta, come simbolo e modello di sequela, nuove figure di attori nel dramma della passione: il Cireneo che porta la croce dietro Gesù, la folla che lo segue battendosi il petto, il buon ladrone, che entra con Gesù in paradiso, il centurione che riconosce in Gesù un uomo giusto, i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito dalla Galilea e infine Giuseppe di Arimatea, un discepolo occulto che si prende cura del corpo di Gesù. Il racconto della morte di Gesù si salda così con quello della cena, al termine della quale Luca ha raccolto le ammonizioni di Gesù riguardanti la sequela, mostrando che essa è l’unica strada aperta al discepolo, anche dopo il trauma del tradimento, per entrare nel regno di Dio da lui annunziato.
Nella seconda lettura Paolo mette in luce come Gesù abbia rifiutato qualsiasi privilegio e si sia fatto solidale con l’umanità accettando la morte più brutale e crudele. Ma proprio in questa umiliazione ha manifestato la grandezza più sublime che gli è stata riconosciuta non solo da Dio ma anche da tutte le creature.

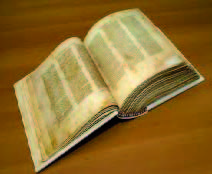

Commenti recenti