Natale – 3) Messa del giorno ABC
La luce nelle tenebre
Nella terza messa di Natale l’attenzione è focalizzata su Gesù in quanto annunciatore di una salvezza che deve raggiungere tutta l’umanità. Nella prima lettura si parla di un lieto annunzio (vangelo) che ha per oggetto la liberazione degli israeliti dall’esilio e il loro ritorno nella terra dei padri. È nell’attuazione di questo progetto che si manifesta la regalità di Dio. Gesù riprenderà questo lieto annunzio e ne mostrerà l’attuazione nella sua predicazione e nei suoi miracoli, fino alla sua morte in croce.
Nel brano del vangelo si afferma che in Gesù si manifesta la parola di Dio, mediante la quale egli ha creato il mondo e ora invia all’umanità. In quanto parola uscita da Padre, Gesù è la luce che illumina ogni uomo. Egli ha lo scopo non di portare una legge ma di manifestare la grazia e la verità di Dio, cioè il suo amore misericordioso per tutti. Per realizzare questo compito Gesù deve scontrarsi con le tenebre, che rappresentano tutti i blocchi che impediscono agli esseri umani di rispondere al progetto di Dio. Ma le tenebre non riusciranno mai a impedire il suo annunzio, neppure quando provocheranno la sua morte in croce.
Come seconda lettura la liturgia propone il prologo della lettera agli Ebrei nel quale si dice che Dio, dopo aver parlato in passato per mezzo dei profeti, ora ha parlato per mezzo del Figlio suo che è irradiazione della sua gloria. È questo Figlio che non solo ha annunziato la parola di Dio ma ha anche compiuto l’espiazione dei peccati, dimostrando così che Dio è più forte della cattiveria umana.
Il Natale rappresenta dunque l’annunzio di una salvezza che consiste nel vincere le violenze di ogni tipo in cui è ancora immersa l’umanità. La venuta di Gesù ha avuto un ruolo determinante in questa lotta cosmica. In quanto Parola di Dio, egli è il rappresentante di tutti quelli che hanno lottato e sono morti per la realizzazione di un mondo migliore. Dal Natale viene l’invito a continuare questa lotta che i suoi discepoli devono continuare in collaborazione con tutti gli uomini e donne di buona volontà.

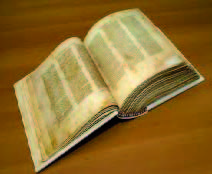

Commenti recenti