Tempo Ordinario A – 13. Domenica
Il tema della liturgia di questa domenica è suggerito dalla prima lettura in cui si parla del profeta e dell’accoglienza che gli è dovuta. Il profeta è l’uomo di Dio che esorta, incoraggia e illumina le menti e i cuori alla ricerca di Dio. Egli tiene desta la speranza in un mondo migliore e aiuta ad anticiparlo nella propria vita e in quella di tutto il popolo. Se denunzia gli errori di chi sbaglia, lo fa non per condannarlo ma per aiutarlo a superare gli ostacoli e a riprendere il cammino. La donna che accoglie Eliseo condivide con lui i valori e gli ideali che egli porta con sé: perciò è piena di devozione nei suoi confronti. Ma non ha figli, è senza futuro. Il profeta, facendole avere un figlio, le apre nuove prospettive, le offre la possibilità di dare un senso alla propria vita.
Nel brano del vangelo sono riportati alcuni detti di Gesù, tratti fuori dal loro contesto originario e qui raccolti come conclusione del «discorso missionario» (Mt 10). Fra essi la liturgia suggerisce di mettere in primo piano quello in cui Gesù afferma che chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Alla luce di questo detto si possono interpretare gli altri che fanno parte della raccolta. Il profeta è il discepolo che ama Gesù più di suo padre e di sua madre, che prende la sua croce e lo segue, che è disposto a perdere la propria vita per causa sua. Egli è un giusto proprio perché si fa piccolo, senza pretesa di potere o di onori. Perciò chi accoglie il discepolo di Gesù accoglie lui e con lui il Padre che lo ha mandato; anche solo chi gli darà un bicchiere d’acqua non perderà la sua ricompensa. Ne consegue che chi accoglie un profeta/discepolo di Gesù perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Ciò significa che una comunità che si rifà a Gesù è tale solo se sa accogliere coloro che hanno il carisma profetico. Se una comunità non accoglie i profeti non può diventare essa stessa profetica e quindi non può essere missionaria, perché la missione consiste nell’aprire gli occhi al futuro di Dio e nell’interpretare i segni dei tempi che egli ha messo sul cammino dell’umanità.
Nella seconda lettura l’apostolo Paolo afferma che, con il battesimo, siamo morti e risuscitati con Cristo. E poi specifica che Cristo è morto al peccato una volta per sempre e ora vive per Dio. Solo diventando un’unica cosa con Gesù possiamo anche noi morire al peccato, cioè combattere contro ogni tipo di ingiustizia e di prevaricazione. Ciò è possibile solo se formiamo una comunità profetica, che annunzia, come ha fatto Gesù, la venuta del regno di Dio.
Una comunità che «uccide» i profeti si appiattisce sul culto, sulle regole morali, sulle gerarchie e sui dogmi fissati una volta per sempre. Così facendo essa non è missionaria e quindi non può pretendere di essere il corpo di Gesù. Solo i profeti infatti danno a una comunità la possibilità di guardare in avanti, di interpretare i segni dei tempi e di annunziare un mondo migliore, basato sulla giustizia e sulla solidarietà.

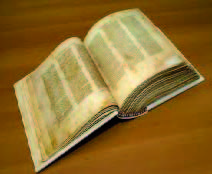

Commenti recenti