Tempo Ordinario C – 15. Domenica
Nella prima lettura si inculca l’osservanza dei comandamenti di Dio, che si riassumono nell’amore di Dio e del prossimo. È interessante che in questo libro la legge dell’amore venga considerata non come oggetto di un’imposizione dall’esterno, fosse pure da parte di Dio, ma come un’esigenza interiore, posta da Dio nell’anima di ogni essere umano, anche se l’egoismo tante volte la oscura e la contraddice.
Nel brano del vangelo Luca mostra come l’amore verso Dio e verso il prossimo sia non solo per Gesù ma anche per i dottori della legge l’unica strada praticabile per ottenere la vita eterna. Il problema si sposta quindi su un altro aspetto di questo insegnamento: chi è il mio prossimo? Come risposta Gesù racconta la parabola del buon samaritano. In essa egli non si limita a sottolineare come l’amore del prossimo consista nella disponibilità ad aiutare chi è nel bisogno, ma mette in questione sia il ruolo della casta sacerdotale sia il rapporto tra giudei e samaritani, che si consideravano vicendevolmente come nemici. Il fatto che l’uomo assalito dai briganti sia un giudeo, mette in luce la gravità del comportamento di due uomini religiosi, un sacerdote e un levita: essi avrebbero dovuto sentirsi coinvolti nella vicenda di quel povero disgraziato non solo per motivi umanitari, ma perché era un giudeo come loro, quindi loro prossimo, che essi erano tenuti ad amare. E invece preferiscono attenersi a semplici prescrizioni riguardanti la purità alle quali come ministri del culto erano tenuti.
Infine nella seconda lettura si parla dell’opera di Cristo come di una riconciliazione di tutte le cose. Non si tratta dunque semplicemente della dovuta riconciliazione tra due persone che hanno litigato, ma di quella pacificazione che sta alla base della convivenza civile all’interno di una nazione o tra nazioni diverse. Tutti devono avere pari diritti e opportunità.
Queste letture mostrano che Gesù ha concepito il regno di Dio come un mondo riconciliato in cui viene eliminata la violenza e vengono abbattuti tutti muri di separazione; un mondo in cui l’amore di Dio non diventa un’alternativa all’amore del prossimo, ma la fonte di una solidarietà che non conosce barriere di alcun tipo, come la razza, il colore, la religione. È questa un’esigenza speciale dei discepoli di Gesù, i quali sono chiamati a non considerare l’altro come prossimo solo quando è vicino o si avvicina a loro, ma di farsi essi stessi prossimo per chiunque è nel bisogno.

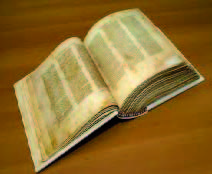

Il comportamento del samaritano è un esempio significativo di quel tipo di amore che scatta nelle situazioni di emergenza. Di fronte a una persona in pericolo o bisognosa, l’amore insegna a non restare indifferenti ma a venirle incontro e a fare il possibile per aiutarla. A volte la generosità spinge non solo a intervenire quando si offre l’occasione ma anche a cercarla per poter fare del bene al proprio prossimo. Il samaritano però dimostra di essere animato da un amore più impegnativo, quello che porta a vedere nell’altro una persona dotata di diritti che devono essere rispettati e difesi anche quando ciò mette in crisi le proprie sicurezze e i propri privilegi: egli infatti non fa distinzione tra giudei e samaritani e paga di persona perché l’altro possa avere ciò che gli compete. Questo tipo di amore è quello di coloro che, per esempio, si impegnano per la pace, per le pari opportunità, per una giustizia più umana. Questo amore non si ferma alle situazioni di emergenza ma si esprime nella partecipazione ad associazioni o movimenti che hanno questo scopo e soprattutto ispira a considerare la propria professione non come fonte di lucro ma come un servizio onesto e disinteressato alla società. L’impegno per una società più giusta e solidale si esercita soprattutto nella partecipazione alla vita politica nelle sue varie manifestazioni: purtroppo questo servizio viene spesso squalificato e lasciato nelle mani di persone incapaci e corrotte mentre dovrebbe essere l’ambito dell’amore più alto. Infine vi è un tipo di amore che è il più importante perché deve pervadere tutti gli altri: esso consiste nell’impegno per la formazione della persona alla libertà e all’amore. È questa una dimensione essenziale del ruolo dei genitori, degli insegnanti, dei formatori in tutti i campi della vita sociale. Questo tipo di sensibilità deve essere soprattutto la caratteristica specifica della comunità cristiana, il cui scopo non è quello di offrire servizi religiosi ma di favorire l’educazione vicendevole dei suoi membri nella ricerca dei valori fondamentali e del senso della vita. Il venir meno a questo compito è ciò che Gesù condanna nella figura dei due religiosi, il sacerdote e il levita, che non hanno avuto misericordia per colui che era stato depredato dai briganti.