Tempo Ordinario C – 16. Domenica
Accoglienza, ascolto e servizio
Il tema di questa liturgia è quello dell’accoglienza, vista come simbolo del rapporto con Gesù e, per mezzo suo, con il Padre. Nella prima lettura la liturgia presenta l’ospitalità di Abramo che, senza saperlo, riceve la visita di Dio. Nel suo comportamento si intrecciano l’impegno per rendere gradevole il soggiorno degli ospiti e l’ascolto di un messaggio importante che gli viene rivolto: entro breve tempo si realizzerà la promessa riguardante la nascita di un figlio, progenitore di un intero popolo.
L’esempio di Abramo serve come chiave di interpretazione per il brano del vangelo nel quale si narra l’accoglienza che Marta e Maria riservano a Gesù. Le due sorelle dimostrano ambedue un grande senso di ospitalità nei suoi confronti. Ma il loro atteggiamento è diverso. Marta, la padrona di casa, rispecchia la preoccupazione di Abramo per gli aspetti materiali dell’ospitalità. Con il suo attivismo ella esprime non solo il desiderio di fare bella figura, ma anche e soprattutto la sua devozione nei confronti di Gesù. Maria invece, interpretando un altro aspetto dell’esempio di Abramo, è più interessata al messaggio e di conseguenza si intrattiene con l’ospite, ascoltando quello che egli le dice. Marta si sente abbandonata dalla sorella e fa a Gesù le sue rimostranze. Pur senza squalificare il suo comportamento, Gesù dimostra chiaramente di preferire quello di Maria. La sua risposta è particolarmente significativa dopo che, con la parabola del buon Samaritano, aveva sottolineato l’importanza del fare come espressione dell’amore del prossimo. Ascoltare e agire sono due facce di una stessa medaglia.
Nella seconda lettura si pone l’accento sulla missione dell’apostolo che consiste nell’essere ministro, cioè servitore della comunità per annunziare, mediante la predicazione del Vangelo, un mistero nascosto da secoli. Questo mistero ha come oggetto Cristo, speranza della gloria futura, da cui dipende la salvezza di tutti, giudei e gentili. L’annunzio della parola prende qui il sopravvento su ogni altro tipo di servizio.
Il servizio dei poveri e dei sofferenti, con i quali Gesù si identifica, ha un posto fondamentale nella sua predicazione. Ma il primato spetta alla comunicazione di un messaggio di speranza, che il credente scopre nel suo rapporto con Dio e dal quale è sostenuto e illuminato nel suo servizio caritativo. Perciò l’ascolto deve sempre precedere e accompagnare l’azione. Questo ascolto costituisce un aspetto essenziale della preghiera, che consiste essenzialmente non nel chiedere qualcosa a Dio ma nell’impegno per comprendere la sua volontà. È significativo che Luca indichi come modello di questo atteggiamento di ascolto non un discepolo di Gesù ma una delle donne che lo seguivano.

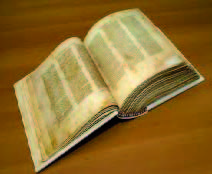

Non in mio nome
Non si può negare che Abramo sia stato veramente fortunato a ricevere una visita di Dio e ad ascoltare direttamente da lui una parola decisiva. E non meno fortunata di lui è stata Maria, la quale ha potuto ascoltare direttamente dalla sua bocca quanto le diceva Gesù, il Messia, l’inviato di Dio. Peccato che a noi Dio non parli mai e quanto ci viene presentato come parola di Dio nella Bibbia è spesso talmente mediato da parole umane da risultarci spesso incomprensibile. L’esempio di quei santi che, aprendo casualmente la Bibbia, vi hanno trovato la parolina che andava bene per loro non mi convince. Quante volte abbiamo pregato, chiesto, implorato, ma nulla. Silenzio totale!
Ma è proprio vero che Dio e lo stesso Gesù tacciono? No, non solo non tacciono, ma urlano, e il loro grido è quello dei poveri, degli sfruttati, degli oppressi. E questo grido penetra nelle profondità del cuore umano, di ogni essere umano, per il quale l’istinto più profondo è quello di considerare l’altro non come un concorrente ma come uno pari a sé, dotato degli stessi diritti e doveri, bisognoso di solidarietà e di assistenza. Questo grido resta inascoltato solo se scatta un perverso meccanismo di rimozione, dettato dal proprio egoismo personale.
Ma certo non basta ascoltare, bisogna dare una risposta, bisogna agire, prendere posizione. E qui subentra Marta. Non so perché era tanto affacendata. Se Gesù dolcemente la rimprovera, un motivo deve pur esserci. Senza voler entrare in merito alle intenzioni di Marta, io vedo in lei rappresentato tutto ciò che riguarda un certo culto alla persona di Gesù, come riti, adorazioni, canti, fiori. Questo indaffararsi intorno alla sua persona infastidisce Gesù perché rimuove la risposta vera, quella che lui si attende da chi ha ascoltato il suo grido.
E questa risposta è riassunta in quattro parole: «Non in mio nome». Tutto il resto viene ci conseguenza. Il dissociarsi dallo sfruttamento dell’altro su cui si basa la società esige il rifiuto dei privilegi che ci vengono dal lavoro sporco fatto da altri: e ciò implica un cambiamento di vita all’insegna della sobrietà, della solidarietà, dell’accoglienza: in altre parole una vita alternativa. Solo dopo si potrà scendere in piazza e protestare contro le ingiustizie fatte contro gli altri, accettando con pazienza quelle di cui personalmente si è vittima.
La comunicazione tra umani avviene in diversi modi e attraverso innumerevoli canali: parole, gesti, scritti, rappresentazioni, film ecc. Nella vita ordinaria la comunicazione per eccellenza è quella che si attua mediante la parola, la quale però è sempre accompagnata da movimenti delle mani, del viso, di tutto il corpo, e si esprime con toni e accenti che spesso completano o a volte cambiano il senso delle parole. Ogni tipo di comunicazione provoca l’ascolto, che è una facoltà innata ma che, come tutte le potenzialità umane, deve essere appresa, elaborata e approfondita. Naturalmente bisogna saper selezionare e verificare le fonti di informazioni. In ogni caso l’ascolto esige un esercizio costante di rielaborazione, si confronto e interpretazione delle informazioni acquisite. In ogni fase dell’ascolto è essenziale il dialogo, senza il quale i malintesi sono frequenti. Alla fine l’ascolto produce le motivazioni che spingono all’azione. Per tutto questo Marta e Maria non rappresentano simbolicamente due tipi di attività autonome ma piuttosto due aspetti complementari del comportamento umano: un ascolto senza azione è puro intellettualismo e l’azione senza previo ascolto sfocia in un attivismo inutile o addirittura dannoso. Queste semplici osservazioni si applicano spontaneamente alla vita spirituale. In essa l’ascolto è fondamentale. Per il cristiano è essenziale il ritorno costante ai testi su cui si basano le sue scelte di vita. Ma questo determina l’ascolto anche di quanto comunicano tutti coloro che sono coinvolti in una ricerca spirituale, ispirata anche da altri orientamenti o scuole religiose o laiche; infine è importante saper leggere (ascoltare) e interpretare i «segni dei tempi», cioè la realtà in cui siamo immersi. Da questo percorso «ascetico» sgorga l’azione a cui porta necessariamente una ricerca spirituale autentica. Solo se proviene dall’ascolto l’azione è efficace e produce il bene di chi opera e di tutta la società. Purtroppo spesso questo processo «spirituale» non viene insegnato e imparato. Perciò abbiamo nel mondo miliardi di persone «religiose» ma non «spirituali», le quali non sono quindi capaci di influire sulla società perché diventi più umana e solidale.