Tempo Ordinario C – 06. Domenica
La liturgia di questa domenica propone alla nostra riflessione un tema molto importante, quello della felicità a cui ognuno di noi aspira. Nella prima lettura il profeta Geremia fa consistere la vera felicità nel confidare nel Signore e non nell’uomo, cioè in se stessi, nelle proprie capacità e in quello che gli altri possono darci. In altre parole, il potere, la gloria, i soldi, il sesso non danno felicità.
Nel brano del vangelo lo stesso tema viene ripreso da Gesù il quale, secondo l’evangelista Luca, indica concretamente chi è veramente felice. Il suo punto di vista è paradossale: sono felici proprio quelle persone che noi riteniamo massimamente infelici: i poveri, gli affamati, coloro che piangono, cioè coloro che appartengono alle classi sociali più umili e diseredate. E ad essi Gesù aggiunge coloro che sono perseguitati per la fede in lui. E per rendere più efficace questo messaggio Gesù aggiunge altrettanti guai rivolti a chi è ricco, a chi ha fame a chi ride e a colui di cui tutti dicono bene: per loro non c’è felicità. Una posizione così radicale si capisce solo nella prospettiva della venuta ormai imminente del regno di Dio, in cui gli ultimi saranno i primi. Luca però doveva fare i conti con il fatto che al suo tempo, parecchi anni dopo la morte di Gesù, la venuta del regno di Dio non sembrava più così imminente. Egli lo sapeva, ma era certo che il messaggio di Gesù, anche in questa nuova situazione, conservava tutta la sua importanza. Certo Gesù non poteva dichiarare beati quelli che soffrono di una povertà estrema; per lui piuttosto sono felici coloro che si mettono dalla loro parte, rinunziando in misura più o meno grande ai loro privilegi per porre le basi di un mondo più giusto e fraterno.
Nella seconda lettura Paolo sposta l’attenzione alla fine dei tempi: un giorno i morti risorgeranno insieme a Gesù, il primo dei risorti, che ha garantito ai suoi discepoli la possibilità di partecipare un giorno alla sua risurrezione. Ma la risurrezione di Gesù opera fin d’ora nei credenti conferendo loro già in questa vita una grande felicità, quella vera, che ha la sua sorgente nell’amore.
Alla luce di tutto l’insegnamento biblico, risulta chiaro che Gesù non rifiuta il possesso dei beni materiali con tutto ciò che comportano, ma il fatto di fondare su essi la propria sicurezza, facendo di essi il fine della propria vita. Tutti i beni di questo mondo diventano sorgente di felicità solo se sono condivisi: chi infatti li cerca non per se stesso, ma per goderne insieme a tutti i fratelli, mette la propria sicurezza non nelle cose materiali ma in quel Dio, che si manifesta nella giustizia e nella fraternità.

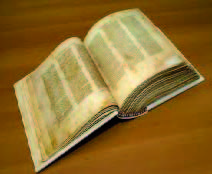

La vera felicità
Chissà se Gesù di beatitudini ne ha pronunziate tre, come riporta Luca, oppure otto come sostiene Matteo. Sì, perché la quarta di Luca e la nona di Matteo sono chiaramente un’aggiunta posteriore, che riflette la reazione dei primi cristiani di fronte alle persecuzioni ormai iniziate. Sinceramente anche solo le tre beatitudini riportate da Luca sono sufficienti per mettere in crisi non solo la società di allora ma anche quella di oggi, divisa in ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Da che parte sta Dio? Gesù lo ha detto chiaramente, non solo qui ma in tutta la sua predicazione. Se il regno di Dio è aperto prima di tutto ai poveri, i ricchi devono farci un pensierino, per non fare una brutta fine. Per questo Luca aggiunge di suo i tre guai, che tolgono ogni illusione a coloro che pensano di essere felici perché possiedono soldi, potere e annessi vari.
Peccato che Gesù sia morto e non sia ritornato puntualmente per inaugurare il promesso regno di Dio. Che fare? Peccato lasciar cadere nel nulla la sua provocazione. E allora ecco che Matteo la attualizza spiegando che la povertà è anzitutto un atteggiamento interiore, che provoca un impegno fattivo per la giustizia, la pace e la fraternità, sulla linea della riflessione di Geremia riportata nella prima lettura.
Luca segue invece un’altra strada, da lui stesso teorizzata nella parabola del ricco epulone. Secondo lui la felicità dei ricchi è illusoria. Con la morte avviene infatti un ribaltore per cui il povero, l’affamato e l’afflitto avranno il premio nei cieli e il ricco precipiterà nell’inferno. Una soluzione allettante, che ha trovato fortuna nei secoli successivi, ma che porta con sé un rischio: quello di servire solo come consolazione per i più diseredati, lasciando il mondo com’è.
Rispetto ai compromessi di Matteo e di Luca, Gesù ha dimostrato di essere più radicale. Che importa se il regno di Dio non è arrivato. Forse è meglio così, perché spetta a noi batterci per un mondo più giusto e fraterno, a tutti i livelli, sapendo pregustare ogni giorno, nel nostro piccolo, un’anticipazione del regno di Dio. Una gioia cioè che è possibile condividere, diversamente da quanto afferma Paolo nella seconda lettura, anche con quanti si impegnano per gli stessi valori senza aspettarsi un premio nell’altra vita.
Le beatitudini, che indicano la via della felicità, rappresentano un paradosso che può essere compreso solo alla luce di tutto il messaggio biblico. Nella Bibbia infatti è radicato il principio secondo cui si può raggiungere la pace e il benessere solo se si tutelano i diritti di tutti, specialmente delle categorie più povere e diseredate (l’orfano, la vedova, il forestiero ecc.). Ne consegue che Dio è dalla parte di costoro e non dei ricchi e dei potenti che li opprimono. Porre la propria fiducia in Dio non vuol dire dunque adottare un atteggiamento fatalistico, aspettando da lui la soluzione dei propri problemi, ma impegnarsi con lui per la giustizia e la solidarietà. Su questo sfondo si capisce il messaggio di Gesù: Dio sta per riprendere la guida del suo popolo (regno di Dio) e i primi a usufruirne sono proprio i poveri, gli affamati, quelli che piangono e non i ricchi e i potenti, i quali saranno privati dei loro privilegi. Dopo qualche decennio, i primi cristiani si sono resi conto che la venuta del regno di Dio, che avevano collegato con il ritorno di Gesù, non era così imminente, ma doveva essere anticipata mediante la ricerca quotidiana della giustizia e della solidarietà. In questa prospettiva le beatitudini (più chiaramente quelle di Matteo ma anche quelle di Luca), non indicano più un ribaltamento imminente della situazione sociale a favore degli ultimi; e neppure contengono l’idea, spesso sostenuta da una certa predicazione, secondo cui chi si è trovato per disgrazia al fondo della scala sociale deve accettare la povertà come condizione per ottenere la felicità nell’altra vita. Le beatitudini invece affermano che è felice chi ha saputo privarsi volontariamente dei propri privilegi, reali o magari solo desiderati, per dedicarsi alla ricerca del bene comune, in un contesto di giustizia e di fraternità. Chi ha fatto questa scelta è disposto ad accettare, senza abbattersi, le sofferenze che essa comporta. È in questa scelta che, secondo il Vangelo, si trova la fonte della vera beatitudine, intesa come realizzazione profonda della propria umanità.