Tempo di quaresima C – 5. Domenica
La liturgia di questa domenica mette in luce il messaggio evangelico del perdono. Nella prima lettura la salvezza viene identificata nel perdono di Dio che consente ai giudei dall’esilio babilonese di ritornare nella loro tera. A nome di Dio il profeta proclama: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova». Egli porta l’immagine di una grande strada che si apre nel deserto. Per essa si incamminano gli esuli che ritornano nella loro terra con la speranza in un mondo nuovo. Il perdono di Dio è orientato al futuro, rende possibile riprendere un cammino che si era bloccato.
Nel brano del vangelo viene proposto il racconto della donna adultera perdonata da Gesù. In realtà Gesù non usa il verbo «perdonare» e neppure chiede alla donna di convertirsi. Egli non entra nel merito di ciò che ha fatto o non fatto: «Neppure io ti giudico». Si limita a non condannarla e le dice: «Va’ e d’ora in poi non peccare più». In altre parole Gesù dimostra chiaramente che il passato, qualunque sia stato, non gli interessa. Per lui è importante il futuro. Per bocca sua Dio indica alla donna, come aveva fatto un giorno con gli esuli di Babilonia, una nuova strada da percorrere. In contrasto con coloro che la volevano lapidare, le dà la speranza di raggiungere anche lei la pienezza del regno di Dio da lui annunziato.
Infine nella seconda lettura Paolo afferma di non aver ancora raggiunto la piena conoscenza di Cristo: egli è ancora in cammino e spera di raggiungere un giorno la perfezione. Anche questa lettura indica una strada da percorrere. I limiti e gli sbagli di ciascuno non hanno importanza. L’unico vero peccato è quello di fermarsi e di non credere più che sia possibile migliorare se stessi e nel mondo in cui abitiamo.
Le letture di questa domenica ci aiutano a superare lo schema tradizionale secondo cui Dio ci perdona perché noi ci pentiamo e gli chiediamo perdono. Secondo Gesù è il perdono di Dio che ci trasforma, ci apre una strada nuova, ci illumina nella ricerca non del nostro interesse personale ma del regno di Dio, cioè di un mondo più giusto e solidale. Anche nei nostri rapporti interpersonali il perdono, come atteggiamento di fondo, deve precedere il pentimento di chi ci ha offesi. Anche la giustizia umana, il cui compito è quello di garantire l’ordine sociale, deve perseguire questo scopo non semplicemente con il rigore della legge ma investendo anzitutto nel recupero di chi ha sbagliato.

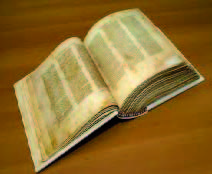

Una giustizia giusta
L’idea di Dio che emerge dalla prima lettura può lasciarci giustamente perplessi. Come immaginare un Dio misericordioso, che sceglie un popolo e lo colma di favori; ma poi, quando va fuori strada, si adira e lo punisce; infine lo perdona, lo libera dall’esilio e lo riconduce nella sua terra? Purtroppo questa immagine è frutto di una cultura in cui Dio è visto nei panni troppo umani di un potente che gestisce i destini di tutto un popolo in termini fortementi paternalistici. Per fortuna nella Bibbia stessa questa immagine di Dio subisce vistosi correttivi. Nel brano scelto dalla liturgia la grande strada che si apre nel deserto per consentire agli esuli di tornare nella loro terra è un’immagine del futuro che si spalanca di fronte a tutti noi: Dio fa una cosa nuova, il passato non conta più. Anche noi, come gli esuli che ritornano nella loro terra, siamo una turba di poveri, sciancati, ciechi, storpi che, cammin facendo, vengono risanati.
L’immagine arcaica di un Dio giudice inflessibile anima quel gruppo di (soli) uomini che portano da Gesù una donna sorpresa in adulterio; essi gli ricordano che la legge prescrive in questi casi la lapidazione dei colpevoli. Un tranello per obbligare Gesù a scegliere tra un Dio giudice inflessibile e un Dio misericordioso. Ma Gesù non si lascia intrappolare. Egli conosce l’ipocrisia di chi lo sta interpellando. D’altra parte non gli sfugge la debolezza di una donna che forse ha pensato di trovare in un affetto illecito il mezzo per evadere da un ambiente familiare oppressivo e discriminante.
Uomini peccatori non possono giudicare una donna ugualmente peccatrice; neppure Gesù la giudica ma la invita ad andare, a rimettersi in cammino, assumendo con coraggio e amore le sue responsabilità. Nessuno è perfetto, ma tutti dobbiamo correre, come dice Paolo, verso la perfezione, senza giudicare gli altri, ma assumendo su di noi le conseguenze dei limiti e degli errori commessi da noi stessi e dagli altri.
Il perdono quindi non consiste in un semplice gesto assolutorio, ma nel tessere rapporti nuovi, in vista di una società più fraterna e solidale. Per fortuna la concezione di una giustizia che non sia punitiva ma riparativa si trova non solo nel vangelo ma anche nella nostra Costituzione. Un tipo di giustizia in forza della quale nessuno è discriminato o abbandonato.
Il popolo che fa da ambiente alla narrativa dell’AT, che quindi rappresenta la loro cultura, è il popolo d’Israele che si è inventato un Dio-giudice, forte, potente e punitivo, a cui addebitare le disgrazie in nome di una legge che lo stesso popolo si è dato.
Là non vige un’etica della responsabilità ma un appaltare all’esterno di sé i comandi, le leggi e le punizioni per le effrazioni. Non è costume chiedersi cosa IO ho sbagliato, dove sono fragile e debole, in quale ambito appaiono le tentazioni e come posso io allontanarle e reagire. Invece abbiamo chiesto al Signore per tanto tempo ‘non indurci in tentazione’ quasi che Lui volesse vederci peccatori ed oggi recitiamo ‘non abbandonarci alla tentazione’. Diverso sarebbe ‘non abbandonarci nella tentazione’ dato che le tentazioni ci accompagnano: dobbiamo imparare a gestirle, a farci forza. Anche gli evangelisti hanno sentito il bisogno di cambiare racconto: Gesù non giudica ma invita l’adultera ad andare, a rimettersi in cammino assumendo con coraggio e amore le sue responsabilità’. A volte è troppo facile chiedere perdono per i misfatti di una collettività o erogare perdono a un singolo. Servono gesti forti, ascolto, incoraggiamento. Noi siamo bisognosi del Suo aiuto e dobbiamo chiederlo attivamente non come passivi peccatori, costretti in questa umanità infantile e dipendente.
Spesso nell’AT Dio è rappresentato come un giudice che condanna Israele in base a una legge che il popolo ha trasgredito e lo punisce severamente fino alla distruzione e all’esilio. Al termine di questa prova dolorosa il registro cambia. La grande strada che si apre nel deserto per consentire agli esuli di tornare nella loro terra è un’immagine del futuro che si spalanca di fronte a questo popolo: Dio fa una cosa nuova, il passato non conta più. Chi si mette in cammino è come una turba di poveri, sciancati, ciechi, storpi che cammin facendo, secondo altri testi del Deuteroisaia, vengono risanati. Gesù è consapevole dei limiti morali del gruppo di uomini che gli portano una donna, sorpresa in adulterio, perché sia lui a pronunziare la condanna. Ma Gesù conosce anche la debolezza di una donna che forse ha pensato di trovare in un affetto illecito il mezzo per evadere da un ambiente familiare oppressivo e discriminante. Uomini peccatori non possono giudicare una donna ugualmente peccatrice e neppure Gesù la giudica ma la invita ad andare, a rimettersi in cammino, assumendo con coraggio e amore le sue responsabilità. Oggi le scienze del comportamento ci hanno fatto conoscere molto più che in passato i condizionamenti a cui sono soggette le nostre scelte. Perciò non dobbiamo giudicare gli altri e neppure noi stessi, ma correre come Paolo verso la perfezione, sapendo che possiamo farlo solo nella misura in cui sappiamo assumere su di noi le conseguenze dei limiti e dei peccati commessi dagli altri, anche nei nostri confronti, affinché nessuno di loro sia scartato. Ciò vale per la chiesa, nella quale il perdono dovrebbe manifestarsi in rapporti nuovi, non solamente rituali, fra le persone. Lo stesso deve avvenire nella famiglia e soprattutto nel campo della giustizia che, anche secondo la nostra Costituzione, deve essere non punitiva ma riabilitativa. Più complesso è il campo dei rapporti politici e geopolitici, nei quali deve farsi strada l’idea di partiti o nazioni che corrono insieme alla ricerca del bene comune.